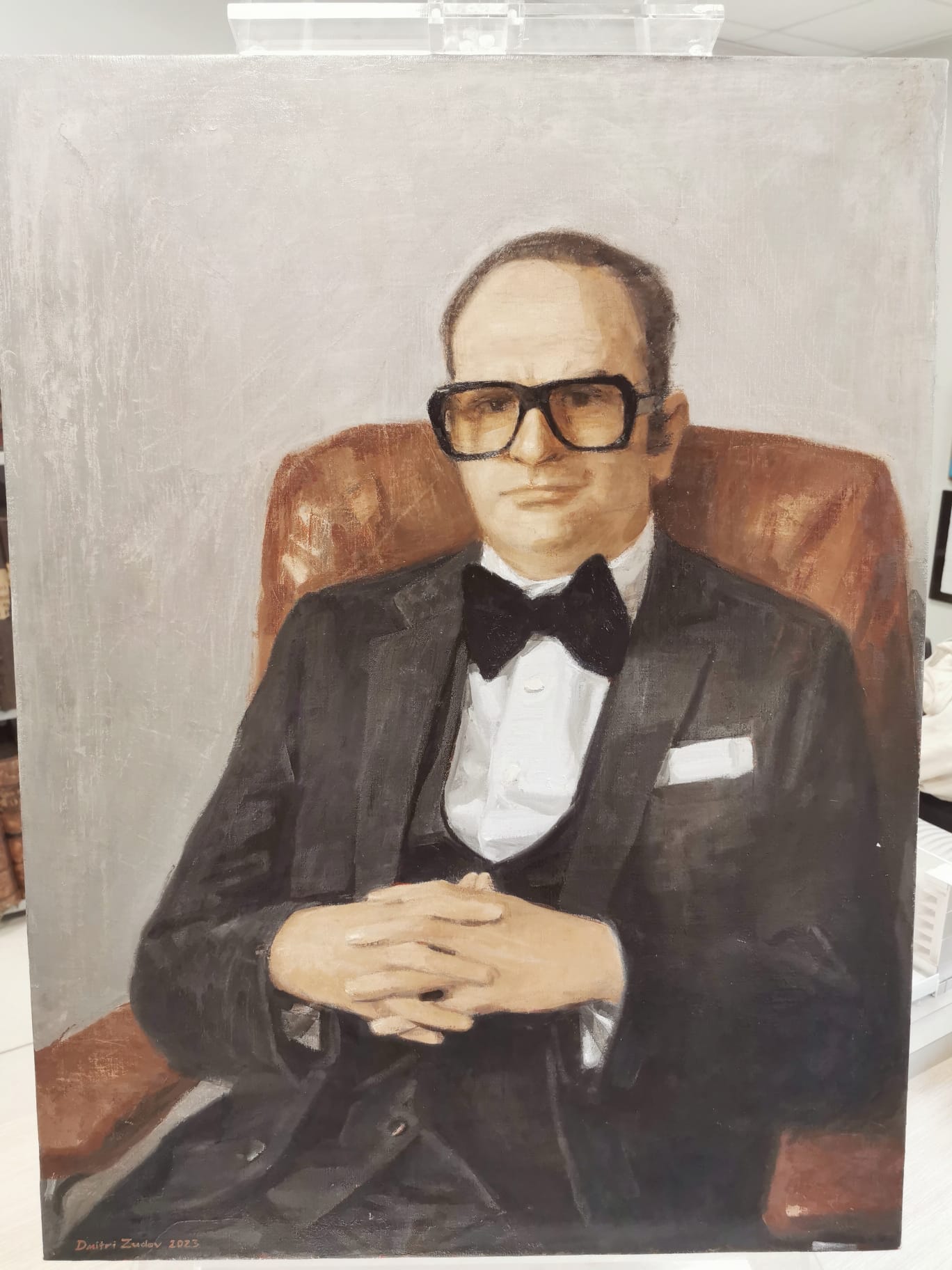Clemente IV, 183° pontefice della Chiesa Cattolica Romana, morì a Viterbo il 29 novembre del 1268. Era allora usanza che i cardinali, tutti elettori del papa senza distinzioni, si radunassero per eleggere il nuovo papa nella Cattedrale della città in cui era morto l’ultimo Pontefice.
Nel 1268 i cardinali erano in totale solo venti, si trovavano quasi tutti tra Italia e Francia ed erano tutti tenuti a eleggere il papa, giacché non c’era limite di età, a differenza di oggi ove i cardinali elettori sono 7 volte di piu e nonostante oltre gli 80 anni non si possa essere elettori.
L’elezione del papa era un fatto assai meno rituale e rigoroso di oggi: i cardinali si recavano a votare una volta al giorno e poi tornavano alle loro faccende. Ciò nonostante l’elezione del papa non era di certo una passeggiata, ma anzi era teatro di scontri feroci tra fazioni, partiti, correnti, famiglie e addirittura nazioni intere, e il fatto che i cardinali fossero pochi e spesso decrepiti non migliorava affatto le cose. A volte occorrevano mesi perché si arrivasse ad una elezione, ma siccome non c’erano i telegiornali e nemmeno i social la cosa non creava certo le aspettative frettolose odierne…
Tuttavia l’lezione di Viterbo è unica nella storia: è durata ben 1006 giorni, 33 mesi circa, dal novembre del 1268 al settembre del 1271…pensate se oggi rimanessimo tre anni senza papa…impensabile.
E in effetti divenne impensabile anche per i placidi fedeli viterbesi, che a un certo punto sfiniti dai continui scontri tra i cardinali filo francesi e guelfi e quelli filo imperiali detti ghibellini decisero di agire. Chiusero porte e finestre del palazzo del papa per obbligare i cardinali a votare continuativamente, passando poi addirittura a ridurre le razioni di acqua e cibo fino a quando si misero ad assaltare il salone dove erano riuniti smontando perfino il tetto per vedere che diamine stessero combinando. Perifino alcuni sovrani europei passarono a vedere cosa stesse accadendo, e a quel punto finalmente i membri del Sacro Collegio delegarono una commissione interna che elesse un religioso piacentino che nemmeno era sacerdote, un tal Visconti che si fece chiamare Gregorio X.
Quello fu il primo conclave della storia, dato che i cardinali furono messi sotto chiave (cum clavis) dal popolo dei fedeli. Da allora in poi le regole del conclave sono state rimaneggiate più volte in senso sempre più rigoroso, fino a quando papa Woytila decise di tornare a rendere la vita dei porporati un po’ piu comoda e il conclave un po’ meno disumano di quanto non fosse divenuto nei secoli.
Resta ancora oggi intatto il fascino intramontabile di un rito millenario che incolla allo schermo miliardi di persone nonostante questa società iper secolarizzata e profondamente atea, divenuta così minimalista e allergica a rituali, pompe e tradizioni. Ma del resto rito e tradizione sono la vera ossatura delle istituzioni religiose, che hanno la caratteristica di rapportarsi con l’eternità molto più che con la contemporaneità, e che hanno ben appreso proprio nel rapporto coi secoli che meno si cambia una cosa e più quella resiste al tempo…
Chi sarà il nuovo papa, da dove verrà e quale direzione farà prendere alla Chiesa o quanta influenza avrà su miliardi di persone nel mondo interessa a noi contemporanei ma non cambia minimamente un rito vecchio di secoli, sempre meravigliosamente uguale a se stesso e che ha in verità un solo scopo, la continuità e la sopravvivenza della Chiesa, corpo mistico di un Dio che decise di farsi uomo e che nonostante tutto ancora oggi incanta perfino i mezzi busti della tv, la categoria forse più disincantata della intera umanità.
Del resto è non a caso la potenza conservativa del rito fu imitata perfino dagli astutissimi vertici del Partito Comunista Sovietico, che fece della elezione e della morte dei suoi leader un rito laico assai simile a quelle infinite splendide liturgie ortodosse che furono proprio linfa vitale di una fede che nemmeno Stalin riuscì a sradicare. E non è certo un caso che la morte del capo sia rimasta in tabù anche nel XX secolo proprio solo in Vaticano e al Cremlino, due estremi opposti eppure per certi versi assai simili.
Francesco Martelli
sovrintendente agli Archivi del Comune di Milano
docente di Archivistica all’Università degli studi di Milano