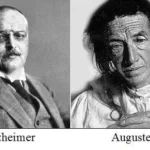Si sa che la storia non si fa con i “se” e con i “ma”. Neppure la storia della medicina. Eppure la rappresentazione teatrale a cui abbiamo assistito venerdì 31 ottobre al San Domenico di Crema induce a porsi almeno alcune domande. La scena è ambientata ai primi del Novecento, nella “Clinica per dementi ed epilettici” di Francoforte sul Meno, dove il signor Deter, impiegato delle ferrovie (Andrea Manni), accompagna la moglie Augusta (Gabriella Tanfoglio) per farla visitare dal primario dottor Alzheimer. La vicenda è raccontata con grande capacità espressiva da una compagnia di attori con la regia di Luciano Bertoli, che interpreta lo stesso Alzheimer. Il motivo di tale argomento è la celebrazione del trentesimo anno dalla fondazione di AIMA Crema (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer). La serata cittadina è ricca di altre iniziative, compresa una frequentatissima lezione del professor Vincenzo Cappelli sulla storia di Crema e, come se non bastasse, è pure Hallowheen.
Ciononostante la sala del teatro si riempie in buona parte e i discorsi preliminari annunciano qualcosa di speciale. Il fatto è che lo spettacolo a cui stiamo per assistere non è frutto della fantasia di qualche geniale drammaturgo, ma è la trasposizione sceneggiata di fatti realmente accaduti, riportati sul testo di Konrad Maurer e Ulrike Maurer Alzheimer. La vita di un medico, la carriera di una malattia tradotto in italiano da Luigi Garzone (Manifestolibri, 1998, 2012, 2015). Il libro venne portato all’attenzione dell’attore e regista Bertoli dal dottor Maurizio Memo, docente di Farmacologia presso l’Università di Brescia, chiamato a testimoniare il proprio contributo nell’introduzione alla serata a cura di Arturo Bettinelli, presidente dell’AIMA Crema. E proprio all’Università di Brescia venne messo in scena per la prima volta nel 2017, sia pure in forma leggermente ridotta. Il titolo dello spettacolo è La cartella di Augusta D.
Dunque entriamo nello studio del dottor Alois Alzheimer in quel 25 novembre del 1901 che segna una tappa significativa per i suoi studi. Egli già praticava un metodo di cura che oggi si definirebbe no restraint, anche se catalogare il dottor Alzheimer come predecessore di Basaglia non sarebbe corretto. Infatti il primo riteneva di dover abolire sistemi di contenzione come camicie di forza o catene, e di presunta cura come l’elettroshock, e su questo sarebbe stato d’accordo con il secondo; ma non proponeva di chiudere i manicomi, ossia di evitare di tenere i malati psichiatrici in un luogo specificamente deputato, cosa che la legge 180 del 1978 decretò, aprendo l’era della cura sul territorio, attraverso i “Dipartimenti di salute mentale” e i reparti di psichiatria degli ospedali. Resta ferma la condivisione del valore fondante, ossia il rispetto della dignità e della persona del paziente.
Nello spettacolo si ripercorrono le tappe della vita dei due, medico e paziente, proprio a partire dal giorno in cui la signora Augusta Deter, accompagnata dal marito, ha modo di farsi conoscere da quel dottore già impegnato con un’équipe di scienziati nell’osservazione sistematica di fenomeni legati ai disturbi mentali. In questo lavoro Alzheimer collabora con il collega Adolf Friedländer (Gabriele Reboni) e l’infermiera Eva (Sara Venosta), mentre Emil Kraepelin (Matteo Bertuetti), dirige la clinica di Monaco di Baviera. Il dottor Alzheimer intrattiene un colloquio con la malata in cui mostra già di saper dosare con grande perizia il distacco tradizionalmente richiesto ai medici per motivi professionali, e l’empatia a suo parere necessaria per conquistarsi la fiducia del malato. Valutazione assolutamente corretta in ogni caso, ma soprattutto con malati di Alzheimer: mai si deve perdere la pazienza (e te la fanno perdere spesso), e sempre si deve tenere un tono di voce deciso ma amorevole, facendo leva su emozioni che non si dileguano con la stessa velocità con cui si sgretola in loro il comune ragionamento logico, di pari passo con la perdita della memoria. Il ricovero è inevitabile, e le cure praticate si articolano fra colloqui, bagni caldi, dieta, e sonniferi solo in caso di agitazione grave. Sullo schermo di fondo vengono proiettate le fotografie che compaiono sul testo citato di K. e U. Maurer. L’attrice che interpreta Augusta D. è molto efficace nel rendere l’idea di confusa agitazione che si impadronisce della malata quando viene avvicinata da medici e infermieri. I sintomi di iperattività motoria oggi vengono generalmente detti wandering. Lei è “piccola e fragile” come nella canzone di Drupi. Ha solo cinquantun anni quando viene ricoverata, tanto che la diagnosi di “demenza senile” dev’essere corretta, potrebbe chiamarsi “presenile”, infine sarà detta “precoce”. Oggi, poiché le scienze parlano in inglese, si direbbe early onset. Oggi sappiamo che l’Alzheimer può colpire a qualunque età. Quel 1901 segna eventi favorevoli per il medico, poiché la clinica di Francoforte viene ampliata, ma pure tragici, come la morte della moglie. Per chi crede nei segni del destino, aggiungiamo che Alzheimer morirà a 51 anni, la stessa età della paziente al momento del ricovero.
Poi il dottor Alzheimer per un certo periodo si trasferisce a Heidelberg e a Monaco di Baviera nella clinica di Emil Kraepelin, destinato a diventare una pietra miliare nella storia della medicina. Siamo negli anni fra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Dopo la Grande Guerra l’universo delle nevrosi e dei traumi da stress post-traumatico verrà totalmente sconvolto dai danni mentali comportati dagli stermini e dalla precaria vita di trincea. Kraepelin aveva inizialmente sintetizzato in un Compendio gli studi di psichiatria. Pubblicato nel 1883 in tedesco, due anni dopo fu tradotto in italiano, e costituì un testo insostituibile per medici e studenti quando, tra il 1910 e il 1915, ne venne pubblicata l’ottava edizione in quattro volumi. L’Italia era allora al centro del dibattito positivistico grazie ad autori come Cesare Lombroso, studioso di frenologia e fondatore dell’antropologia criminale. In Europa si affermavano correnti di pensiero sperimentalista anche in medicina: in Germania, in particolare, basta ricordare i nomi di Jacob Moleschott e di Ernst Haeckel. Si trattava di un approccio materialista e forse un po’ meccanicistico che comunque valorizzava i contributi di chimica, biochimica e batteriologia. Anche l’Italia diede il suo contributo a questo indirizzo ad esempio con Arnaldo Cantani, considerato il fondatore della medicina sperimentale.
Questi spunti positivistici non furono ininfluenti nello sviluppo delle ricerche del dottor Alzheimer, il quale fra l’altro divenne amico di Franz Nissl, che aveva introdotto il metodo della colorazione istologica nello studio dei fenomeni patologici delle cellule nervose. Un riferimento a quel metodo è presente nello spettacolo teatrale, quando compare Gaetano Perusini impegnato nell’osservare al microscopio alcune parti del cervello dove le alterazioni neuronali presenti nella demenza senile vengono evidenziate grazie al metodo della colorazione istologica. Merito dello studioso italiano fu l’aver interpretato la sostanza costituente le placche, oggi nota come proteina Beta-amiloide, come “un prodotto metabolico patologico” allora “di origine sconosciuta” che si comportava come “una specie di cemento che incolla le fibrille insieme”. Nel copione dello spettacolo Alzheimer domanda a se stesso e ai collaboratori più di una volta “proteine?”, e la risposta è “forse”.
La malattia sconosciuta verrà dapprima definita “demenza di Alzheimer- Perusini”, finché Kraepelin nel suo trattato Psichiatria del 1910 la classificherà come “malattia di Alzheimer”. Infine la guerra si porterà via ogni cosa, non prima che le ricerche di Alzheimer venissero in gran parte ignorate o misconosciute dalla medicina ufficiale. Perché? Innanzitutto perché le tradizioni consolidate sono difficili da sradicare, e in secondo luogo perché nel primo Novecento stava diffondendosi la psicanalisi freudiana, peraltro anch’essa per lungo tempo sminuita ed emarginata sia per motivi “scientifici”, ossia la prevalenza dei metodi organicisti in psichiatria, sia religiosi, dal momento che la Chiesa ne osteggiava il “pessimismo” e la trattazione disinibita di tematiche sessuali. Nella rappresentazione di Bertoli, Alzheimer confessa che la psicanalisi gli sembra sopravvalutare l’incidenza della sessualità nelle nevrosi, ma certo non lo dice con intento moralistico. Quando poi la concorrenza della psicanalisi mise in ombra le sue scoperte, egli dichiara amaramente “il divano ha rimpiazzato il microscopio”.
Tornando alla storia dei “se” e dei “ma”, ci domandiamo: se è vero che il dottor Alzheimer se ne andò da Francoforte perché furono tagliati i fondi per la sua ricerca, che cosa sarebbe accaduto se invece quei fondi gli fossero stati confermati? La diagnosi dettagliata, supportata dalla frequente comparazione del cervello di un deceduto sano (in una scena i medici analizzano il cervello di un uomo morto a cent’anni compiuti) con quello di un deceduto malato, avrebbe portato ad una terapia efficace? E se invece la psicanalisi si fosse appropriata dell’intera gestione della malattia, sarebbe riuscita a curarla? Se i metodi freudiani prevedono il colloquio, l’associazione di idee e l’interpretazione dei sogni, il problema sarebbe come e con che cosa sostituire la narrazione del paziente nevrotico, da cui lo psicanalista ricava elementi per indagare nel suo inconscio. Teniamo presente che anche l’interpretazione dei sogni consiste nell’interpretazione di una narrazione che il malato fa dei propri sogni. Ebbene, è lecito domandarsi che ne sarebbe del povero malato di Alzheimer, dal momento che fra i sintomi ricorrenti del morbo compare un disturbo dell’eloquio. Quest’ultimo si può manifestare come un parlare continuo fra sé e sé, un borbottio, una ripetizione di frasi sconnesse, un enunciare nessi logici in modo inusuale; in seguito come una sostituzione di parole nel loro carattere denotativo, una perdita progressiva del lessico, che a volte viene sommerso da fonemi e sillabe incoerenti e insignificanti, fino a giungere alla totale afasia. Ricordiamo che Kraepelin, che fra l’altro fu uno dei primi discepoli di Wundt a Lipsia (si insegna che la Psicologia nacque come scienza nel 1879, quando Wilhelm Wundt fondò a Lipsia il primo laboratorio di psicologia sperimentale) pubblicò articoli sui disturbi del linguaggio nei sogni, il cosiddetto “linguaggio onirico”.
Allora che cosa ricaveremmo da queste considerazioni? Forse che i due indirizzi di studio farebbero bene a collaborare, anziché contrastarsi a vicenda. Solo da un approccio integrale che possa avvalersi di un metodo scientificamente comprovato potrà forse un giorno venire scoperta la chiave per entrare davvero nel cuore, nel corpo, nella mente e nel cervello del malato di Alzheimer, senza – ahimé – dover attendere post mortem un’autopsia che confermi o smentisca con certezza che “quello era Alzheimer”, ma non sapevamo come curarlo.
Patrizia de Capua