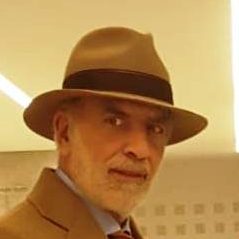«Perché io pago le tasse». E il cittadino giustamente si sente autorizzato a pretendere dagli amministratori pubblici locali le strade pulite, asfaltate e prive di buche. Poi il taglio dell’erba sul ciglio della strada e il funzionamento dei giochi dei bambini nel parco. Ancora, i cestini dei rifiuti vuoti e i marciapiedi liberi dalle cacche dei cani. Infine, la sostituzione in tempo reale delle lampadine pubbliche fulminate.
«Perché io pago le tasse». E il cittadino, ignaro della differenza tra pubblico e privato, si sente autorizzato a chiedere ai pubblici amministratori di intervenire perché la siepe del confinante invade la sua proprietà. Perché il vicino parcheggia l’auto in uno spazio pubblico senza divieti, ma a lui non gradito. Perché il coinquilino ascolta la musica troppo alta, ma entro i limiti permessi dalla legge.
Poi c’è il saggio di fine anno della scuola dell’infanzia, con i bambini in partenza per il teatro, distante trecento metri, ma la pioggia incombe. Che fare? Diamine, una telefonata per l’utilizzo dello scuolabus. Per affrontare l’emergenza Indiana Jones sarebbe stato più gradito ai piccoli. Pazienza, non si può avere tutto.
«Perché io pago le tasse». E il cittadino si sente autorizzato a pretendere tutto, proprio tutto, dalla pubblica amministrazione e, manco a dirlo, senza pagare. A gratis.
Se riceve un niet, la rivendicazione si tramuta in clava, mazza da baseball, caterpillar per demolire l’efficienza della pubblica amministrazione. Per metterla alla gogna e sottoporla al processo del tribunale dei social, più intransigente, integralista e ottuso di quello della rivoluzione francese, pilastro del periodo del terrore. Con una differenza: allora all’imputato veniva mozzata la testa, oggi gli vengono triturati gli organi intimi. E si può considerare un gesto di clemenza.
«Perché io pago le tasse» è la motivazione più contraddittoria, inconsistente e insostenibile per rivendicare il diritto di un servizio pubblico.
Primo, il richiedente potrebbe pagare le tasse, ma meno del dovuto.
Secondo, la pubblica amministrazione eroga servizi per tutti i cittadini. Anche per i più sfortunati, che le tasse non le pagano perché con redditi incompatibili con una sopravvivenza dignitosa.
Terzo, è una affermazione generica che non giustifica né la necessità, né il diritto di avere il servizio richiesto.
Quarto, è una formula irrispettosa della buona educazione e della convivenza civile. Indizio di scarso senso civico.
Quinto, è il salvacondotto per mostrare i muscoli. Surrogato locale di «Piove, governo ladro». Culturismo di protervia e boria. Becera ignoranza.
Questo è il lato più noto del pianeta della pubblica amministrazione. Il più mediatico, formaggio per topi da tastiera, roditori-odiatori ubiquitari che abbondano e imperversano anche nel nostro territorio.
Poi ne esiste un altro meno conosciuto, contraltare dell’antipatico, irritante e inaccettabile io pago le tasse e ho diritto. Non è l’inquietante e minaccioso dark side oggi di moda, bensì un cono d’ombra. Uno spazio che, se illuminato, consentirebbe di sfatare alcuni pregiudizi tossici sul rapporto tra pubblico e privato. Un’opportunità per migliorare il dialogo tra cittadini ed amministratori pubblici. Per ridurre la conflittualità e agevolare il rapporto tra gli irriducibili dell’io pago le tasse e ho diritto e gli enti locali. Per trasformare il duello rusticano in un confronto che difficilmente sarà tra gentiluomini ottocenteschi, ma probabilmente risulterà più costruttivo dell’attuale. Lo scontro con la baionetta, la sfida esasperata tra finti samurai, non giova a nessuno dei contendenti. Non risolve i problemi. Radicalizza le contrapposizioni. Non affronta le controversie, ma le amplifica.
Al di là dell’inflazionato luogo comune che vuole sempre sconfitte le istituzioni, in questi frangenti esse non soccombono mai. I perdenti sono comunque i cittadini.
La ragione per accendere i riflettori sul cono d’ombra si trova nel discorso di insediamento (20 gennaio 1961) del presidente americano John Kennedy. Sta nel famosissimo: «Non chiedete cosa il vostro paese può fare per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese» che smonta l’assioma «pago le tasse e ho diritto». Ma soprattutto si trova nel meno noto passaggio: «Non dobbiamo mai negoziare per timore, ma non dobbiamo mai aver timore di negoziare». Un invito al dialogo. Alla rinuncia alla rigidità. Alla ricerca della condivisione, senza calare i pantaloni.
Incoronarsi Masaniello di serie C del terzo millennio per opporsi in modo strumentale ai pubblici amministratori non migliora situazioni critiche. Le esaspera. Più costruttivo lavorare insieme per trovare soluzioni ai problemi.
Chi paga le tasse detiene il sacrosanto diritto di usufruire di servizi pubblici adeguati, ma non può esimersi dall’onere di essere parte attiva del sistema Stato, Regione, Provincia, Comune. Concetto spesso dimenticato e quasi mai interiorizzato.
Chi paga le tasse ha il dovere di stimolare gli amministratori. Di collaborare con le istituzioni affinché le risorse da lui stesso versate vengano gestite in modo oculato. Per evitare di sprecarle nello svuotamento dei cestini-discarica e nella pulizia dei marciapiedi-cessi per cani.
Chi paga le tasse non può ergersi a paladino dei diritti ed essere il primo a scansarli. Personalizzare le rivendicazioni non giova a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione. Contrapporsi ad essa nel narcisistico tentativo di mostrare ai concittadini la consistenza dei propri attribuiti virili, non porta consenso. È vacuo masochismo. Sterile esibizionismo. E si corre il rischio di trovare qualcuno più dotato.
Per par condicio, agli amministratori pubblici è proibito rintanarsi nella turris eburnea delle istituzioni, lontano dai cittadini. Nel contempo, è auspicabile l’esercizio dell’autonomia concessa dalla legge e l’opposizione a decisioni imposte da partiti senza un loro coinvolgimento. Chi rappresentano i partiti? Snaturati e ridimensionati nel ruolo di corpi intermedi, ridotti ad aggregazioni corporative, si arrabattano per la salvaguardia dei propri interessi, garantiti dal potere delle sedie occupate dai fedelissimi.
Un capitolo a parte meritano le partecipate. Difenderle sempre e comunque anche in quei casi di fallimento palese e certificato è un suicidio politico-amministrativo. Così come è inammissibile l’accanimento terapeutico per mantenere in vita le società in coma profondo. Scelta finalizzata al mantenimento di un poltronificio, terreno di baratto della confraternita della spartizione.
Da non sottovalutare il rapporto con comitati, gruppi, rompicoglioni tout court – si anche loro – portatori di istanze in contrasto con le scelte degli amministratori pubblici.
Il confronto e la dialettica sono la democrazia stessa.
Io pago le tasse e ho diritto è demagogia.
Io sono stato eletto e comando è prepotenza.
I cestini-discarica, i marciapiedi sporchi, sono soldi delle tasse gettati al vento.
L’accanimento terapeutico su partecipate terminali, una vergogna.
La politica e la pubblica amministrazione sono un altro pianeta.
La negoziazione kennediana un’arte difficile e rischiosa per i quaquaraquà ai vertici della piramide.
Ma non tutto è perduto. Contro i sensi vietati, le strade del possibile. Un ricordo. Senza nostalgia e rimpianti.
Antonio Grassi
.