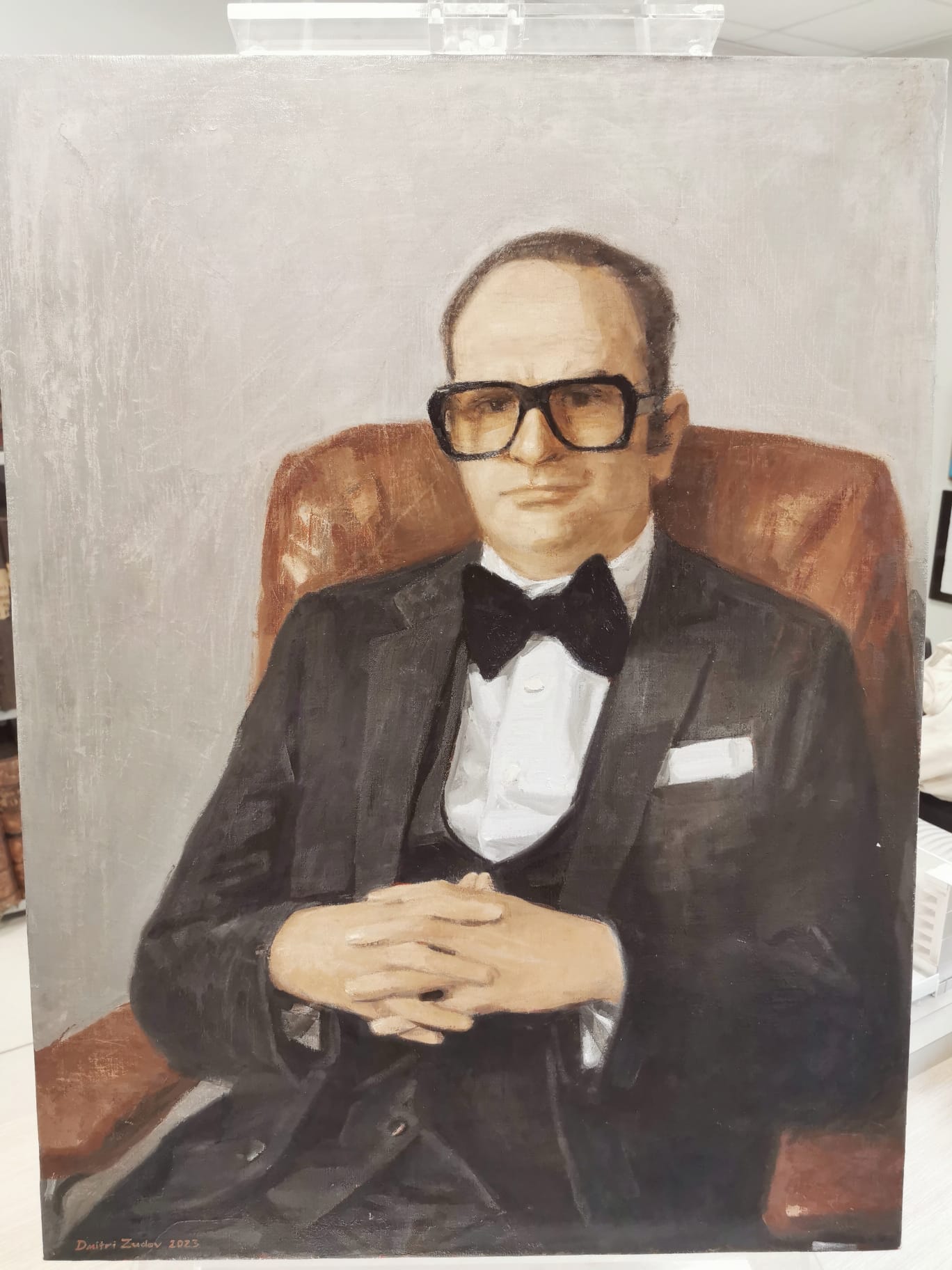Quest’anno l’Italia celebra gli 80 anni della Liberazione dal fascismo, e in tutto il Paese vastissime saranno le celebrazioni, e tanto avremo modo di parlarne nei nostri editoriali.
Cade però un altro anniversario che chi scrive si domanda se verrà celebrato e, nel caso, come. Mi riferisco alla morte, nell’agosto del 1964, di Palmiro Togliatti, fondatore (assieme a Gramsci) e guida del Partito Comunista Italiano.
Chi come me è cresciuto in una famiglia alto borghese dalle lunghe e solide tradizioni anticomuniste e ha frequentato gli ultimi democristiani, Togliatti lo ha spesso sentito apostrofare come un “delinquentone”, termine non del tutto dispregiativo ma che indicava una critica severa eppur bonaria verso uno che aveva fatto cose riprovevoli ma in fondo aveva le “palle quadrate”. Il motivo era semplicemente uno: Togliatti era stalinista. Ed è lo stesso motivo per cui poi negli anni è stato sepolto nell’oblio anche dalla sinistra italiana. E di Stalin ha in effetti seguito il destino tra i suoi: idolatrato in vita, trattato con imbarazzo da morto.
Ma Togliatti rimane un gigantesco uomo politico, uno dei migliori dell’era repubblicana e a cui l’Italia deve molto soprattutto nel difficilissimo passaggio alla età republicana. Sì è vero, su di lui pesano come macigni i silenzi assensi verso tutti gli orrori commessi da Stalin. Ma di Stalin egli aveva la adamantina cognizione strategica. Quella capacità di visione che per realizzare una strategia vincente e ideale non si ferma nemmeno davanti ai morti. L’ideale era il Comunismo, la strategia era il pragmatismo vittorioso. Certo Togliatti non vinse le elezioni del 1948 e consegnò l’Italia ai democristiani, ma vinse tutto ciò che poteva vincere, è cioè costruire in Italia dentro la Nato il più solido, ampio ed efficiente partito comunista del mondo libero. E lo fece avendo chiaro sempre che era un italiano in Italia, cose che certamente condivideva con quel genio assoluto della politica che era il Georgiano: senza Stalin Togliatti non prendeva decisioni cruciali, e sempre obbedì a Stalin, cosa che non gli impedì di definire con storica lucidità lo stalinismo come “l’eterna infamia”, frase che è ben più politica che storica. E Stalin, che niente faceva a caso, non a caso scelse Togliatti come capo del comunismo italiano (lasciando volentieri che il troszkista Gramsci morisse nelle galere fasciste), e se lo tenne a Mosca per quasi 15 anni durante i quali secondo alcuni venne addirittura rieducato fino alla spersonalizzazione. Togliatti era stalinista: ma a chi doveva mai andar dietro un lucido dirigente comunista in quegli anni se non all’uomo che prese una Russia medioevale e ne fece la padrona di mezzo mondo? E Stalin, che fece strage ripetutamente dei dirigenti del partito, non si è privato di coloro che avevano due caratteristiche essenziali, capire il Disegno ed esservi fedeli in modo assoluto.
Togliatti era un personaggio tragico in tempi tragici come ebbe a dire Cecilia Kin, uno che non avrebbe esitato a far entrare l’Armata Rossa in Italia per imporre una dittatura nel 1945 (come testimoniato dai carteggi con Stalin), e a cui però si devono due momenti eccezionali e salvifici proprio per la affermazione della democrazia in Italia, la svolta di Salerno e la l’amnistia ai fascisti. A Salerno nel ‘43 convince i comunisti italiani a lottare assieme ai democristiani e agli americani per salvare l’Italia dai nazi-fascisti e con l’amnistia da ministro della Giustizia chiude definitivamente la stagione delle vendette e della guerra civile. Decisioni anche queste prese assieme alla genialità pragmatica di Stalin. Anche quando sarà oggetto di un attentato, Togliatti saprà essere uomo di dialogo e moderazione, evitando ancora una volta il rischio di una guerra civile. Non era bontà, era netta visione politica e pragmatismo intelligente.
Quando nel 1956 Krusciov lancerà la destalinizzazione, Togliatti sarà l’unico a sollevare in pubblico durante il congresso del Pcus un dubbio severo capendo che demolire il mito di Stalin era un errore politico immane, eppure contemporaneamente sarà molto critico rispetto alla stretta liberticida che l’Urss andava imponendo nei Paesi satelliti.
Togliatti, lucido come pochi, aveva ben compreso quello che non capi Krusciov: che gettare a mare Stalin per tenersi lo stalinismo era un errore tragico, Andava salvato il mito di Stalin e cambiato in senso democratico lo stalinismo, e infatti apprezzò taluni sforzi di Krusciov in quel senso, pur rimanendo sempre molto critico verso il nuovo contraddittorio corso dell’Urss. E se gli avessero dato retta chissà, forse oggi l’Urss sarebbe al posto della Cina. E infatti Togliatti cercò di minimizzare, tornato in Italia, la destalinizzazione, sostenendo spesso che era impossibile ottenere gli straordinari risultati dell’Urss se a comandare fosse stato un mostro pazzo.
“Togliatti ha fatto sopravvivere il PCI perché da partito rivoluzionario di avanguardia clandestina lo ha trasformato in un partito socialdemocratico di integrazione sociale delle masse” diceva Alfredo Reichling, e anche se la scelta un po’ socialdemocratica gli sarebbe costata il gulag ai tempi del Georgiano, nell’Italia del dopoguerra fu un scelta intelligentissima.
Morì proprio in quell’Unione Sovietica che lo idolatrava e che gli dedicò perfino una città, mentre stendeva un Memoriale in quella Yalta dove stava per incontrare quel Krusciov con cui non andava d’accordo, e che solo due mesi dopo verrà non a caso detronizzato da Breznev.
Un uomo dagli straordinari meriti e dai giganteschi peccati, che merita a 60 anni dalla morte nuovi studi e riflessioni.
Francesco Martelli
sovrintendente agli Archivi del Comune di Milano
docente di Archivistica all’Università degli studi di Milano