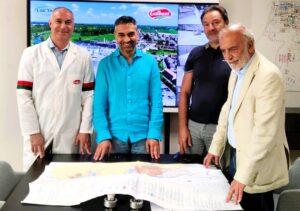Il gruppo consiliare in Provincia Centrodestra per Cremona, formato da rappresentanti della Lega e di Forza Italia, ha presentato una mozione al presidente Roberto Mariani con richiesta di convocazione urgente del Consiglio provinciale per la trattazione della mozione avente come oggetto la situazione economico-finanziaria di Centropadane Engineering srl e la revoca immediata dei licenziamenti.
Ecco il testo.
PREMESSO CHE
- nelle settimane scorse abbiamo lanciato l’allarme sulla situazione economico finanziaria della società in house a partecipazione pubblica Centropadane Engineering srl; • per questa ragione, a metà luglio, come gruppo Centrodestra per Cremona, abbiamo depositato un ordine del giorno richiedendo fosse discusso nel primo consiglio utile; • nonostante fosse pendente la richiesta del nostro ordine del giorno, è stato fissato per il 30 Luglio il Consiglio Provinciale con un solo punto all’ordine del giorno relativo all’assestamento di bilancio;
- circa 48 ore prima dal Consiglio Provinciale abbiamo ricevuto un’integrazione dell’Ordine del giorno con la proposta di delibera del Piano di Risanamento aziendale (120 pagine compreso gli allegati) predisposto e approvato in data 23 luglio 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società Centropadane Engineering srl ;
CONSIDERATO CHE
- il testo della delibera del punto integrativo dell’ordine del giorno testualmente recitava che il Consiglio Provinciale “prende atto e approva il piano di risanamento della società Centropadane Engineering srl come approvato dal CdA in data 23 luglio 2025”;
- nelle ore successive il sindacato che rappresenta i lavoratori, analizzato il Piano di Risanamento, invitava pubblicamente i Presidenti delle Province di Cremona e di Brescia a non approvarne il contenuto e a riprendere il tavolo sindacale bruscamente interrotto dai vertici della società;
- durante il Consiglio provinciale di mercoledì 30 luglio il presidente Mariani, in maniera tanto ambigua quanto frettolosa, proponeva di emendare la delibera predisposta dallo stesso due giorni prima, togliendo dal testo il termine “approva” ma accettando di fatto con una “presa d’atto” il Piano di risanamento proposto;
- solamente il gruppo Centrodestra per Cremona votava contro l’approvazione della delibera;
PRESO ATTO CHE
- nemmeno dodici ore dopo la delibera di “presa d’atto” del Consiglio provinciale, giovedì mattina 31 luglio, il Direttore generale della società convocava quattro dipendenti consegnando loro la lettera di licenziamento;
- nella stessa giornata, dopo il licenziamento dei quattro dipendenti, altri tre dipendenti rassegnavano le dimissioni;
RITENUTO CHE
- come più volte denunciato da questo Gruppo consiliare, siamo di fronte ad un fatto di una gravità inaudita e senza precedenti per una società a totale capitale pubblico;
- i licenziamenti dei quattro dipendenti sono una scelta brutale e ingiustificata che calpesta la dignità e i diritti dei lavoratori, chiamati ingiustamente a pagare il prezzo delle scelte di rappresentanti politici che non hanno voluto palesemente assumersi, attraverso il voto contrario, le proprie responsabilità;
- ci siano forti perplessità sulla legittimità della motivazione che sottende ai licenziamenti, considerando che la crisi aziendale non è dovuta a criticità di mercato, ma solo dal mancato conferimento degli incarichi alla società da parte dai soci, in particolare dalla Provincia di Cremona;
- sia necessario che non solo il presidente Mariani e l’attuale maggioranza, ma tutto il Consiglio provinciale, si assumano le proprie responsabilità, sia politiche sia in qualità di soci titolari del 49% delle quote societarie;
il Consiglio provinciale
impegna il Presidente della Provincia a chiedere ai vertici della società di
- revocare immediatamente i licenziamenti già eseguiti ai danni dei quattro dipendenti, reintegrandoli nel proprio posto di lavoro;
- sospendere qualsiasi ulteriore azione finalizzata ad un eventuale piano di dimensionamento sempre ai danni dei lavoratori.
- ristabilire le corrette relazioni sindacali, come richiesto dai sindacati; 4. redigere un nuovo Piano di Risanamento che tuteli realmente gli interessi degli enti soci e la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie.
Il Gruppo consiliare provinciale Centrodestra per Cremona Lega e FI
Valeria Patelli
Giovanni Rossoni
Filippo Raglio